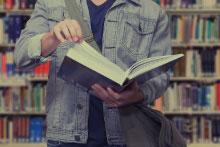Caratteristiche del corso
Struttura del corso
Bando
Allegati al bando
Esiti
Comunicazioni ed aggiornamenti
Gli esami orali di ammissione al Dottorato di Ricerca in “Economics and Finance of Territorial Sustainability and Well-being” – XLI ciclo, originariamente previsti per l'8 settembre 2025, sono stati rinviati.
La nuova data per il colloquio sarà resa nota con un preavviso minimo di 20 giorni.
Si conferma che la prova orale avverrà in modalità telematica per tutti i candidati.
Contenuti generali del corso
I sistemi produttivi e i territori sono chiamati a rispondere a eventi epocali, quali il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il consumo eccessivo di risorse naturali, la sempre maggiore necessità di approvvigionamenti da fonti energetiche pulite, la produzione eccessiva di materiali di scarto, la robotizzazione, le migrazioni di massa ecc., che impongono inevitabili percorsi di transizione a livello sia locale sia globale.
La complessità crescente di questi fenomeni pone sfide sempre più ardue che richiedono approcci multidisciplinari e traversali al fine di fornire gli strumenti adeguati a interventi rivolti alle dimensioni sociali, ambientali ed economiche dei sistemi territoriali. Dalle dinamiche di queste dimensioni sistemiche e dalle relative interconnessioni dipendono, a loro volta, equilibri interni ed esterni. Gli equilibri sistemici sono alla base del concetto di sostenibilità, requisito essenziale per preservare il futuro dei territori garantendone la sopravvivenza. I suddetti cambiamenti stanno pregiudicando severamente la sostenibilità dei sistemi e fanno emergere l’impellente necessità di interventi volti a rendere i sistemi territoriali resilienti, caratteristica basilare per consentire una continua e costante ridefinizione degli equilibri sociali, ambientali ed economici nel tempo e nello spazio. Ciò significa che gli attori sociali ed economici, che attraverso le loro scelte determinano le sorti di tali sistemi, devono essere in grado di intraprendere tempestivamente ed in maniera esaustiva percorsi di adattamento, attivare misure volte a mitigare i rischi e sviluppare capacità di reazione a shock esogeni inattesi.
In risposta a questi scenari, la Commissione Europea, accanto Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, ha designato il piano straordinario e ambizioso NextGenerationEU che alloca circa 800 mld di euro. La quasi totalità delle risorse sono veicolate verso gli stati membri attraverso il Piano “Recovery and Resilience Facility”, interpretato a livello nazionale con i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR). Essi insistono nel sistema nazione su linee direttrici che, a prescindere del tipo di sistema territoriale/settoriale, impongono dei percorsi volti alla convergenza territoriale e alle cosiddette transizioni gemelle: ambientale e digitale.
Il CdDR vuole sviluppare delle competenze altamente qualificate al servizio dell’attuazione del PNRR italiano, ed in linea col Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, con specifico focus sulla sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori. Si tratta di un’offerta didattica sviluppata su due tematiche principali.
La prima tematica attiene allo sviluppo di competenze multidisciplinari volte all’analisi della sostenibilità sociale, ambientale, economico-finanziaria e giuridica al fine di fornire, nel rispetto delle fonti normative interne e comunitarie, nonché dei sovraordinati principi costituzionali e dei trattati internazionali, soluzioni per lo sviluppo sostenibile attraverso l’utilizzo di modelli territoriali/settoriali e approcci quantitativi che approssimino al meglio le varie transizioni. La seconda tematica insiste sullo sviluppo di competenze volte allo sviluppo di metodi e strumenti quantitativi matematico-statistici, nonché di politica economica, che devono servire e facilitare la reale attuazione dei modelli di sviluppo territoriale di cui alla prima direttrice tematica.
Entrambe le tematiche sono, dunque, complementari e reciproche. Tale reciprocità è a beneficio della interdisciplinarità richiamata nel PNR 2021-2027. Facendo leva su quest’ultimo, un altro elemento trasversale riguarda la tipologia di progetti di ricerca che saranno approvati. Essi, infatti, saranno in linea con l’approccio Mission-Oriented Research and Innovation Policy (MOIP), il cui presupposto è che siano orientati al perseguimento di processi innovativi i quali non saranno misurati solo nella intensità ma anche nella direzione perseguita. Essa deve essere guidata dalle traiettorie delle ambiziose grandi missioni tratteggiate dalle macro-politiche europee (es. Green Deal, missioni di Horizon Europe, EU's digital strategy ecc.) e dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) inquadrati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Questo impianto strategico consente una sinergica interconnessione degli obiettivi delle politiche orizzontali come ricerca e innovazione, formazione, abilità, apprendistato, con quelle verticali come ambiente, energia, lavoro ecc. (Mazzucato, 2018).
Obiettivi formativi
Il CdDR è stato progettato con l’intento di rispondere alle molteplici transizioni che si stanno realizzando a livello locale e globale. Ad esso sottendono obiettivi di carattere generale e specifico. Gli obiettivi generali derivano dall’esigenza di offrire delle risposte ai sistemi territoriali nel loro insieme, cercando di perseguire delle ricadute di ampio respiro sui territori così come configurato dalle politiche europee e dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Essi possono essere sintetizzati come segue:
- Contribuire al pieno compimento delle transizioni ambientali e digitali entro i termini e le traiettorie definiti dall’European Green Deal, dall’EU's digital strategy e dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
- Contribuire alla creazione di reti territoriali al fine attivare effetti reciproche contaminazioni (spillover) tra gli attori territoriali e ridurre i divari territoriali;
- Instaurare un canale diretto di interlocuzione e scambio con le realtà produttive (pubbliche e private), data la caratterizzazione industriale della proposta, per attivare processi di innovazione volti al compimento delle transizioni.
Gli obiettivi specifici, invece, attengono alle specifiche misure e declinazioni della proposta di CdDR nel quadro degli obiettivi generali. Nel caso di questa proposta si fa riferimento ai seguenti obiettivi specifici:
- Creazione di una figura professionale che possegga competenze avanzate e complesse, in linea con le nuove professionalità aderenti alle esigenze della nuova geografia del lavoro (territorio, settore, professione) volta al compimento delle transizioni;
- Creare delle professionalità poliedriche capaci di guidare le organizzazioni pubbliche e private a cogliere le molteplici opportunità derivanti da un contesto dinamico in continua evoluzione, così da realizzare la loro resilienza e, in conseguenza, quella dei sistemi territoriali;
- Creare delle figure professionali che siano in grado di capitalizzare i risultati delle ricerche finanziate dal PNRR (Partenariati Estesi, Ecosistemi Territoriali, Campioni Nazionali ecc.) attraverso la loro azione nelle università, spinoff, imprese, pubbliche amministrazioni;
- Ridurre il divario tra le competenze di formazione di terzo livello offerta dalle università con quanto richiesto dal mondo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;
- Aumentare la permanenza delle professionalità altamente qualificate sul territorio meridionale al fine di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, nonché attivare delle ricadute territoriali a beneficio dell’inclusione sociale.
Attività didattiche
Insegnamenti previsti
- Linguistica
- Informatica
- Gestione della ricerca e della conoscenza
- Sistemi di ricerca e sistemi di finanziamento
- Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale
- Finanza sostenibile
- Geografia delle disuguaglianze
- Ambiente e tutela della salute
- Digitalizzazione dei sistemi territoriali: focus sulle aree rurali
- Econometria dei dati panel
- Economia e Politica del Benessere
- Metodi matematici e statistici per l’economia, la finanza, l’ambiente
- Economia e valutazione ambientale
Altre attività didattiche
- Attività di laboratorio
- Seminari
Requisiti di ammissione
Tutte le lauree magistrali
Sbocchi occupazionali e professionali
Il percorso didattico seguito dai dottorandi conferirà loro le competenze interdisciplinari al servizio delle transizioni attuali e future. Applicheranno le conoscenze acquisite incarnando lo spirito del PNR 2021-2027 che pone le persone al centro dei processi di innovazione veicolati dai risultati della ricerca (“human-centric innovation”). I dottori di ricerca saranno in grado di interpretare i diversi livelli dell’indice Social Readiness Level (SRL) che associa ai diversi gradi di Technology Readiness Level (TRL) le risorse umane adeguate a poterli implementare, capitalizzando la capacità di esprimere, in sinergia, competenze orizzontali e verticali.
I dottori di ricerca coglieranno le opportunità lavorative derivanti dai grandi cambiamenti portati dagli investimenti del PNRR: saranno i cosiddetti Research facilitator for innovation che avranno il compito di trasferire i risultati della ricerca dagli organismi in cui essa viene sviluppata ai sistemi produttivi territoriali. Troveranno opportunità lavorative come economisti, esperti di transizioni in senso lato, risk manager, consulenti giuridici nella fase attuativa della transizione e nella predisposizione dei necessari strumenti negoziali, analisti finanziari di dati e sviluppatori di metodologie di analisi, nonché di politiche all'interno di organizzazioni pubbliche e private di varia natura: università; centri di ricerca pubblici/privati, pubbliche amministrazioni, grandi imprese, spinoff, start-up e altre piccole medie imprese dinamiche e ad alto potenziale di innovazione.
La versatilità dei loro profili non restringe le opportunità ad uno o un insieme ristretto di risvolti lavorativi, bensì li rende adatti alla dinamicità e imprevedibilità dei cambiamenti nel mercato del lavoro. Infatti, saranno essi stessi fautori principali dei dinamismi di contesto, proponendo traiettorie di sviluppo e divenendo attori principali dei conseguenti cambiamenti. Potranno infatti contribuire a ridurre il corrente gap tecnologico tra offerta e domanda di lavoro, agevolando a sua volta l’assunzione delle figure professionali più innovative che il mercato di lavoro oggi offre.